L’Association of National Advertisers ha pubblicato il Report
L’associazione ha commissionato alla società investigativa K2 un’indagine su questo argomento, da cui è emerso che su 117 fonti attive coinvolte dal sondaggio, ben 59 sono state testimoni di pratiche di business non corrette
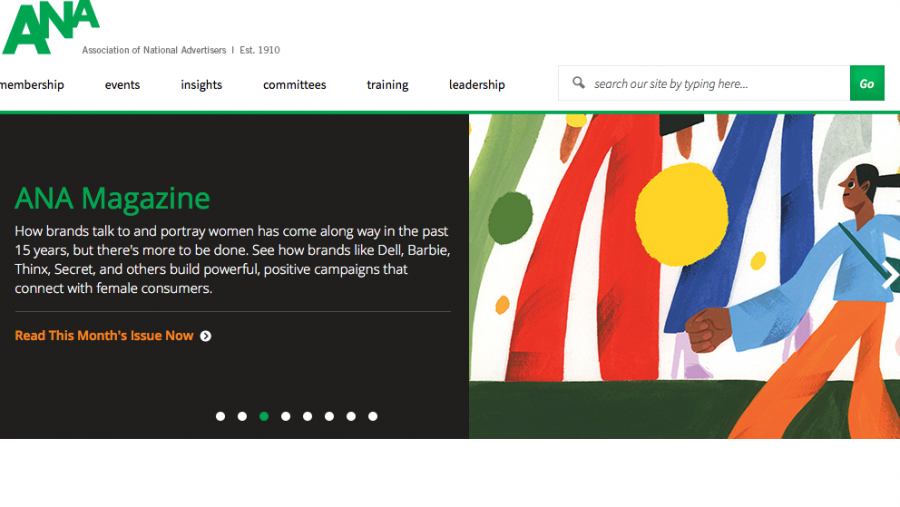
È servito un po’ di tempo, ma alla fine l’Association of National Advertisers ha pubblicato il tanto atteso report sulla media-transparency. E i risultati hanno acceso gli animi di marketer e agenzie, che si sono prodigati in commenti e reazioni di vario tipo. Ma andiamo con ordine. L’associazione ha commissionato alla società investigativa K2 un rapporto sulla trasparenza dei media, da cui è emerso che su 117 fonti, attive nel segmento media-buying, coinvolte nel sondaggio, 59 hanno raccontato di esperienze dirette con pratiche di business non del tutto trasparenti. Di queste, 34 sono entrate in contatto con il “rebate”, una pratica che negli Stati Uniti non è mai stata oggetto di attenzione pubblica come invece è avvenuto in Europa. Basti pensare alla famosa Loi Sapin, che negli anni ’90 fu utilizzata per normare la materia delle cosiddette “overcommission”. Nello specifico, molti provider di tecnologie pubblicitarie si sono sentiti costretti ad accettare dei contratti con le agenzie che fondamentalmente richiedevano una restituzione parziale degli investimenti. Le compagnie ad tech avrebbero dovuto sostenere costi legati a servizi extra offerti dalle agenzie, come report e ricerche, di cui effettivamente non risultavano avere necessità, per poter entrare a far parte dell’elenco dei vendor da selezionare. In secondo luogo, i markup correlati al media sold attraverso le principali transazioni erano fissati tra il 30 e il 90% e i media buyer sarebbero stati invitati a trattenere le eventuali quote di saving invece di indirizzarle a beneficio del cliente. Per finire, il ceo di una società di ad tech, di cui non è stata rivelata l’identità, avrebbe affermato che da una media holding gli sarebbe arrivata l’offerta di una percentuale di azioni della struttura in cambio di flussi di denaro da destinare a quest’ultima nel corso delle varie negoziazioni. A queste accuse se ne aggiungono altre, ad esempio il riferimento a prassi caratterizzate dalla non condivisione con i clienti di eventuali risparmi. “Dallo studio è emerso che i casi in cui sono stati pagati i “rebate alle agenzie” oscillerebbero tra l’1,6 e il 20% del valore dell’aggregate media spending, a seconda del contratto» spiega Richard Plansky, executive managing director of K2 Intelligence . “La maggior parte di questi problemi è emersa nel segmento digital. E in parte, questa situazione è dovuta alla transizione del business e alla velocità con cui è cambiato” ha spiegato il presidente dell’Ana, Bob Liodice. L’associazione ha comunque deciso di mantenere segrete le identità di coloro che hanno risposto durante il monitoraggio e molto probabilmente non tutti i player del settore ad tech possono chiamarsi fuori dal sistema. Il comune denominatore che si evince dal report propone, comunque, un’evidenza: le agenzie non sarebbero assolutamente trasparenti e gli advertiser non sanno fino in fondo dove sta andando parte del proprio investimento.
I primi commenti
“Siamo sconvolti. Questo è un brutto giorno per la industry. Le agenzie hanno categoricamente smentito, per anni, che gli Stati Uniti fossero un mercato che accettasse il “rebate”. A questo punto non saremmo sorpresi se i brand si dovessero sentire profondamente delusi dalle loro agenzie - commenta Tom Denford, co-founder di ID Comms - . Gli Stati Uniti hanno sempre sostenuto di essere un mercato pulito nel segmento media marketing, oltre a essere il più grande mercato del mondo. Adesso sappiamo che non è proprio così. Inevitabilmente questa situazione metterà in dubbio le convinzioni dei marketer su tutti i mercati media del mondo perché se gli Stati Uniti, che si sono sempre dichiarati immacolati, sono intaccati dalla cultura del “rebate”, a chi dovremmo credere? L’integrità dell’intera industry è messa in forte dubbio”. Sul report si è espresso anche Graham Brown, co-founder della media advisory firm Media Sense, secondo cui la ricerca offre una fotografia “non sorprendente, ma deludente” nel mondo dei centri media. “Sono contento che la questione sia venuta a galla e spero che i clienti e le agenzie si decidano, ora, ad avviare una riflessione sul tema per trovare misure appropriate sulla gestione degli investimenti - continua Brown - . Per ripristinare la fiducia richiesta in questo ecosistema di lavoro è necessario stipulare dei contratti ferrei con governance e relazioni appropriate”. “I senior executive di una media agency di New York ora si trovano in una posizione scomoda e si aspettano che i cmo delle company si facciano vivi per chiedere spiegazioni immediate. Questo report ha “scioccato” i marketer statunitensi” aggiunge preoccipato Denford.
La risposta delle media agency
Non hanno impiegato molto per controbattere i centri media americani. A partire da Jerry Buhlmann, ceo di Dentsu Aegis Network, che afferma: “Il report di Ana è inconsistente ed è costruito su metodologie soggettive e input anonimi. Le pratiche di business a cui si riferisce non esistono all’interno del nostro operato in Usa. Il nostro processo di media buying è robusto e trasparente, soggetto a norme rigorose; e tutti i nostri clienti hanno la possibilità di verificarlo. In più, siamo fieri delle nostre effort per la verifica delle policy, delle pratiche e del controllo”. Interpublic Group fa sapere che “IPG è leader nella media trasparency dal 2005, quando abbiamo proattivamente confrontato le pratiche non-trasparenti emerse ora nel report di Ana. Abbiamo eliminato queste pratiche dalla nostra organizzazione e pubblicato informative a riguardo, rafforzando la nostra governance sui controlli. Da quel momento abbiamo continuato a modernizzare le nostre pratiche di trasparenza per adeguarle a un media landscape che integra il digitale e risulta, quindi, più complesso. In IPG non accettiamo “rebate” negli Stati Uniti e non crediamo possano essere parte delle pratiche del mercato statunitense. Inoltre, IPG non acquista inventory media, ma si fanno pre-acquisti media dal nostro stesso account per poi rivenderli ai clienti. Questa decisione è stata scelta per differenziare la nostra company dalle altre. Come risultato, disponiamo di un alto livello di chiarezza nei nostri contratti con i clienti e i media owner, che coinvolgono i rispettivi ruoli e interessi. Le nostre pratiche passano attraverso varie revisioni condotte su richiesta dei clienti da diverse società terze, tra cui alcune di quelle che hanno partecipato al report dell’Ana. La vasta e anonima natura delle accuse formulate nel report è infelice e provocatoria. La fotografia descritta è inconsistente se riferita alle nostre pratiche di business attuali”. GroupM commenta così: “Il report di Ana e l’obiettività dei suoi autori e advisor devono essere esaminati attentamente. Alla ricerca non può essere permesso di indebolire l’intera industry e neppure una sola company al suo interno. GroupM non chiede ne accetta alcun “rebate” o revenue nascosta, sotto nessuna forma, dai media partner statunitensi; e non accettiamo service fee dai vendors che non siano resi noti ai clienti. GroupM è cristallina con i clienti preoccupati per i prodotti delle nostre media property e per il valore che questi consegnano. E gli stessi clienti esercitano sempre un opt-in informato per partecipare. Insistiamo perché Ana condivida dati specifici sul nostro gruppo insieme a noi, così da poter rassicurare sulla conformità dei nostri contratti. Se i clienti hanno qualche dubbio o perplessità siamo qui per rispondere”. Conclude Publicis Groupe, che si unisce al coro dei dissensi verso la ricerca: “Capiamo perfettamente che i clienti abbiano bisogno di essere certi che i loro investimenti siano gestiti in maniera professionale e in accordo con il contratto che hanno firmato. La fiducia reciproca, da decenni, è uno dei pilastri del nostro gruppo. Se l’Ana avesse avuto intenzione di instaurare un dialogo aperto con la nostra industry saremmo stati pronti a cooperare, come abbiamo fatto l’anno scorso in occasione del nostro convolgimento con 4A. Rifiutando questo dialogo e scegliendo un approccio sensazionalistico, sembra chiaro che Ana non sta cercando una soluzione a questi presunti problemi, ma che abbia invece altri obiettivi in mente. Ana ha deluso i suoi membri, gli advertiser, le agenzie e l’intera industry, pubblicando un report che si basa su presunzioni legate a situazioni che coinvolgono company e individui mai nominati per costruire affermazioni fuorvianti, insostenibili e non verificabili. La ricerca non porta alcun risultato costruttivo, nessun incoraggiamento a un miglioramento utile per assicurare che gli advertiser e le agenzie siano ben equipaggiate per lavorare insieme in un media environment in rapida evoluzione. Nella lettera che abbiamo spedito a 4A lo scorso 30 maggio, prima che il report fosse rilasciato, avevamo già sottolineato le nostre preoccupazioni riguardo all’approccio utilizzato da Ana, ma sono state ignorate”. Comunque sia, “Publicis Groupe ha regole interne molto strette, incluso un code of conduct che svolge un importante compito di controllo sulle nostre pratice e sui rapporti pubblici. Inoltre, esaminiamo continuamente processi e procedure, per essere sicuri di seguire le best practices; e tutti i nostri dipendenti devono seguire questi standard. Siamo cristallini, impegnati a conseguire la piena conformità dei termini dei contratti che firmiamo con i clienti”.








